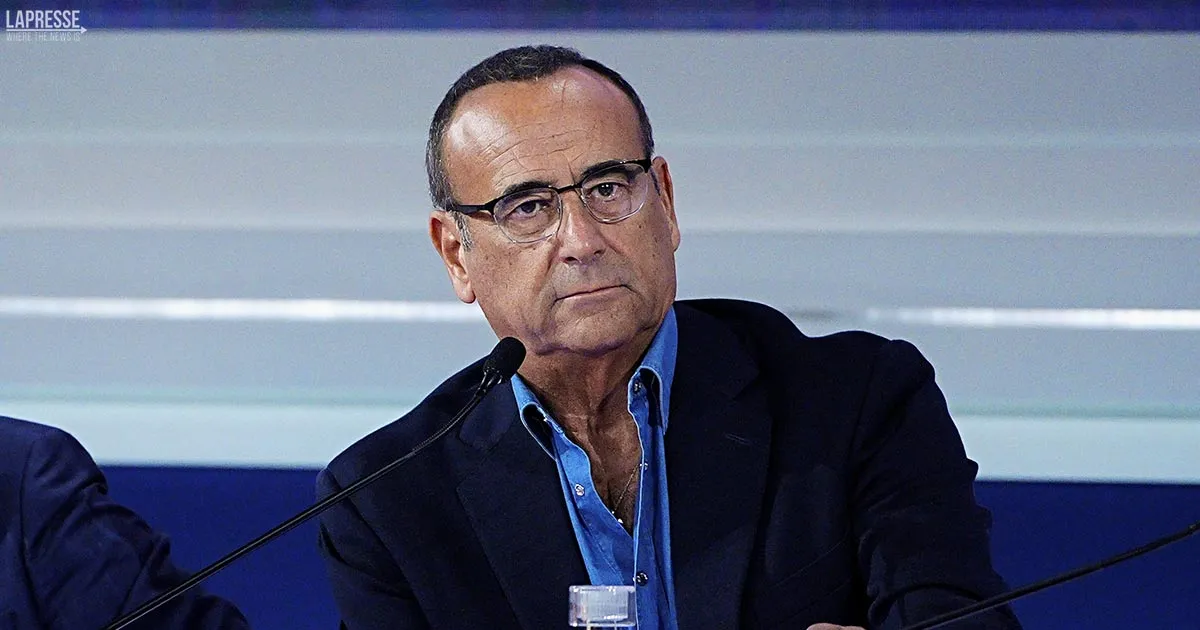“Chiamami col tuo nome”: il miglior film del nuovo cinema italiano secondo il New York Times

La scorsa settimana, il New York Times ha pubblicato un attesissimo elenco: i 100 film più rilevanti del XXI secolo. A stilare la classifica sono stati oltre cinquecento professionisti del settore cinematografico, tra registi, attori e critici, e il risultato ha offerto lo spunto per un ampio dibattito culturale. Che cosa definisce oggi un “grande film”? Qual è il nuovo canone cinematografico dal 2000 in poi? E soprattutto: è possibile rompere l’egemonia statunitense nel racconto del mondo attraverso il cinema?
Le risposte a queste domande devono necessariamente partire da un dato fondamentale: la maggioranza degli intervistati lavora all’interno dell’industria hollywoodiana. Questo si riflette direttamente nella composizione della classifica, dove circa il 60% dei titoli selezionati è di produzione americana.
Un solo titolo italiano nella lista: “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino
Analizzando i risultati, un fatto salta immediatamente all’occhio: solo un film italiano è riuscito a entrare in classifica, ed è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, posizionato al numero 37. Il film, tratto dal romanzo di André Aciman e uscito nel 2017, è stato accolto con entusiasmo dalla critica americana ben prima che in Italia. Un riconoscimento importante, certo, ma anche sintomo di una presenza italiana ormai marginale nel panorama cinematografico globale.

Tra anglocentrismo e aperture internazionali: la complessa geografia della classifica
Nonostante l’evidente impronta anglosassone, la classifica del New York Times non ignora completamente il cinema non occidentale. A occupare il primo posto è Parasite (2019) del regista sudcoreano Bong Joon-ho, un thriller sociale diventato simbolo di un cinema globale e plurilinguistico.
Altri esempi di apertura includono:
- In the Mood for Love di Wong Kar-wai (Hong Kong),
- La città incantata di Hayao Miyazaki (Giappone),
- City of God di Fernando Meirelles (Brasile),
- La tigre e il dragone di Ang Lee (Taiwan),
- Y tu mamá también di Alfonso Cuarón (Messico).
Per quanto riguarda l’Europa, la presenza è più limitata. Il titolo europeo meglio posizionato è La zona d’interesse di Jonathan Glazer, un’opera britannica ma girata in lingua tedesca, che si colloca al dodicesimo posto. A livello nazionale, la Germania compare con Le vite degli altri e Vi presento Toni Erdmann, mentre la Francia è rappresentata da sei film, tra cui Anatomia di una caduta, Il profeta, Ritratto della giovane in fiamme, Amélie, Amour e La vita è un raccolto.
Il grande assente: il cinema italiano e la sua crisi d’internazionalizzazione
Il dato che fa riflettere è questo: il cinema italiano occupa solo l’1% della classifica. Un’anomalia? Forse. Un segnale? Sicuramente. Soprattutto se si considera che nelle liste dei “più grandi film di tutti i tempi” figurano regolarmente capolavori italiani come:
- La dolce vita e 8½ di Federico Fellini,
- Ladri di biciclette di Vittorio De Sica,
- Viaggio in Italia di Roberto Rossellini,
- L’avventura di Michelangelo Antonioni,
- Il Gattopardo di Luchino Visconti.
È lecito chiedersi: com’è possibile che un Paese con una tale eredità culturale e cinematografica sia oggi quasi assente nel racconto del presente?
Guadagnino sì, ma gli altri? I limiti della portabilità culturale
Il caso di Luca Guadagnino sembra l’unica eccezione. Ma cosa lo distingue dagli altri registi italiani contemporanei? Perché, ad esempio, nomi come Nanni Moretti o Marco Bellocchio, pur autori di opere importanti, non sono riusciti a imporsi a livello globale?
Moretti ha vinto la Palma d’Oro nel 2001 con La stanza del figlio, eppure il film ha avuto un impatto piuttosto limitato fuori dall’Europa. Marco Bellocchio, con titoli come Buongiorno, notte, Vincere e Il traditore, ha realizzato pellicole di grande forza, ma fortemente radicate nel contesto storico-politico italiano, rendendo difficile una loro lettura universale per il pubblico internazionale.
Cinema vs letteratura: il paradosso Ferrante
Un altro elemento interessante emerge confrontando il cinema italiano con la letteratura nazionale. Quando il New York Times ha stilato la sua classifica dei 100 migliori libri del XXI secolo, al primo posto si è posizionato L’amica geniale di Elena Ferrante, presente anche con La figlia oscura e I giorni dell’abbandono.
È dunque lecito domandarsi: com’è possibile che la narrativa italiana riesca a conquistare l’attenzione internazionale con così tanta forza, mentre il nostro cinema arranca?
Quale futuro per il cinema italiano?
Il cinema italiano sembra attraversare una crisi di risonanza internazionale, più che di qualità. I talenti ci sono, i temi anche. Ma è forse l’incapacità di rendere questi contenuti “esportabili” che limita il nostro impatto globale.
Chiamami col tuo nome ha funzionato anche perché parlava all’anima, ma con un’estetica internazionale e una produzione in gran parte straniera. Serve ripensare il modo in cui raccontiamo le nostre storie, affinché diventino comprensibili – e toccanti – per chi sta al di fuori dei nostri confini.